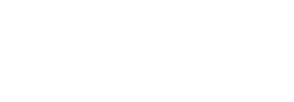Approfondimenti
NUMERO 14 – L’illusionista del pallone
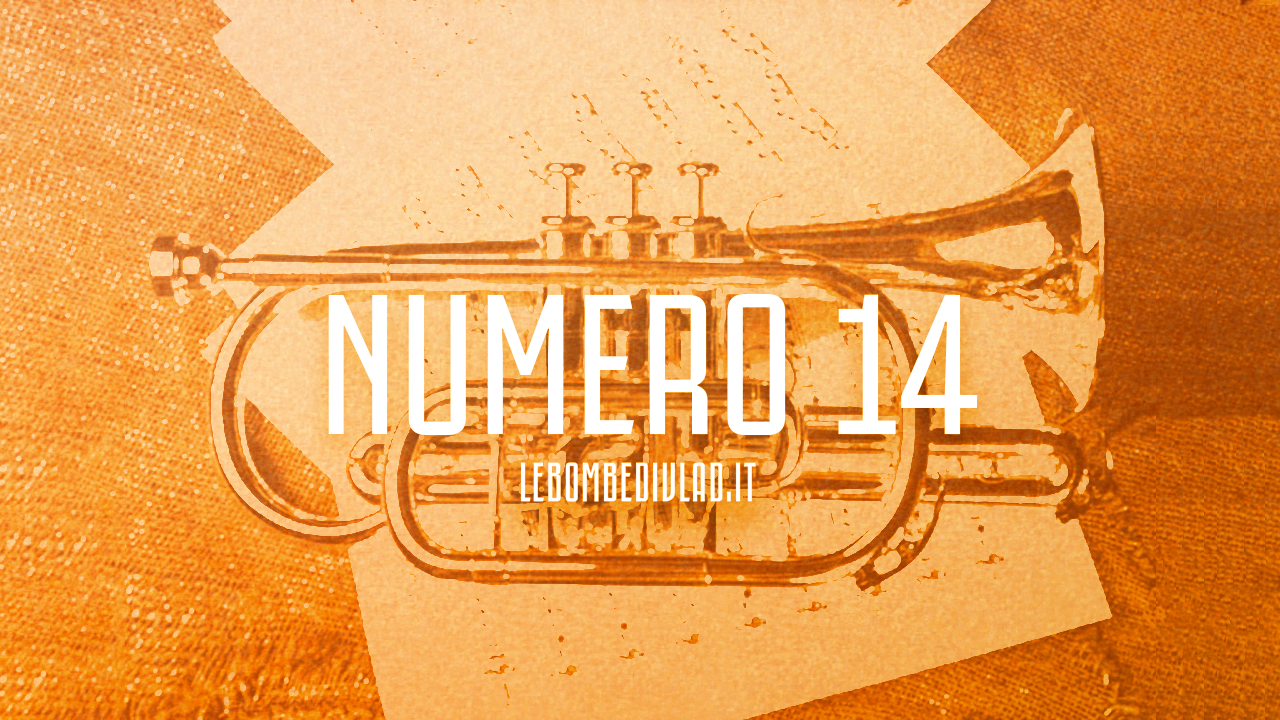
Il suo emblematico soprannome era “Mandrake”, come il famoso mago dei comics statunitensi. E gli calzava a pennello, niente avrebbe potuto spiegare meglio le caratteristiche di Mario Corso, numero 11 dell’Inter degli Anni Sessanta e Settanta, autentico illusionista del pallone. Poi, a riprova dei tanti aspetti del personaggio, c’erano anche epiteti meno gratificanti, come quel “participio passato del verbo correre”, coniato appositamente per lui da un fuoriclasse della cronaca sportiva come Gianni Brera.
Croce e delizia
Era fatto cosi, quel giovanotto veneto magro ed allampanato: talento da vendere ma sempre dispensato a tratti. E solo nei periodi di vena. Croce e delizia: non era raro, nei momenti di scarsa ispirazione, vederlo passeggiare per il campo. Indolente per natura, apatico ai rimbrotti dalla panchina, refrattario allo sforzo atletico. Eppure le sue doti lo avevano portato all’Inter ancora minorenne e l’esordio era arrivato subito, con un impegno da far tremare le gambe. L’allenatore, il giorno del suo debutto, lo aveva inserito in formazione al posto di Lennart “Nacka” Skoglund (cfr. “Il demone nella bottiglia”), il fuoriclasse scandinavo capace di infiammare lo stadio con i suoi guizzi sulla fascia. Non era stata una decisione avventata: il ragazzo era l’unico ad avere le carte in regola per sostituire l’estroso campione svedese. Gli somigliava molto: la fiducia nei propri mezzi tecnici (amava infilarsi le noccioline nella tasca con virtuosistici colpi di tacco) era già abbastanza alta da fargli osare dribbling in spazi ristrettissimi, il suo piede sinistro era già abbastanza rodato da poter disegnare lanci millimetrici. E il suo ego è abbastanza forte da poter scendere in campo con i calzettoni abbassati alla caviglia, come il suo idolo Omar Sivori (cfr. “Il capoclasse e il monello”). Con queste premesse e, a dispetto della carta d’identità, il posto da titolare è ben presto suo, tanti suoi più navigati compagni di squadra devono cedergli il passo. E l’eco dei mugugni di spogliatoio viene ben presto zittito dai suoi pezzi di bravura in campo, primo fra tutti quello che diverrà il suo marchio di fabbrica, la punizione a “foglia morta”.
Pezzi d’autore
Il pezzo migliore del suo repertorio era ispirato ad un autentico maestro, Didi, il regista della nazionale brasiliana campione del mondo. A causa di un infortunio alla gamba aveva inventato un particolare modo di calciare le punizioni colpendo la palla con le sole prime tre dita del piede. Il risultato erano state dei palloni scagliati verso la porta avversaria con traiettorie imprevedibili per qualsiasi portiere, esattamente come delle foglie cadute dall’albero che si posano in luoghi impensabili. Corso, sfruttando il suo magico sinistro, riesce nell’impresa di emulare il brasiliano, beffando gli estremi difensori di mezza Italia. Non sempre la ciambella gli riesce con il buco ma, quando il suo mancino buca la rete, sono sempre gol d’autore. Il pubblico di San Siro stravede per lui, cosi come la Signora Erminia Moratti, moglie del Presidentissimo Angelo. Si reca allo stadio quasi solo per lui, sicura che il mago con la maglia numero 11 saprà tirare fuori dal suo cilindro qualche colpo ad effetto per stupirla.
Conflitto di personalità
Nell’estate del 1960 arriva sulla panchina della squadra nerazzurra l’allenatore argentino Helenio Herrera. Il nuovo tecnico ha una personalità debordante e gli piace da morire essere sempre e comunque al centro dell’attenzione (cfr. “La prima star della panchina”). E, come se non bastasse, è un cultore del calcio praticato alla massima velocità possibile. Fatale che i due non si gradiscano, ben presto è guerra aperta. Il trainer sudamericano trova che Corso sia troppo lento per i suoi schemi e sopporta a fatica i suoi preziosismi in campo, paragonandoli con ironia a numeri da circo. Gli preferisce, di gran lunga, un regista classico come Luis Suarez, molto più adatto al suo gioco. Dal canto suo il giocatore disprezza apertamente i metodi di lavoro del tecnico, bollandoli come “fatica inutile”. Per lui, abituato a fare affidamento solo sulla sua tecnica, gli interminabili discorsi tattici del mister sono solo le vanterie di un ciarlatano. E, un giorno, quando la consueta arringa prepartita di Herrera, si conclude con l’annuncio di una vittoria certa, non si fa scrupolo di sottolineare che “sarebbe interessante sapere cosa ne pensano nello spogliatoio accanto”. Nella stanza scende il gelo: tutti sono in imbarazzo, nessuno aveva mai osato contestare l’allenatore in questo modo. Alla fine della partita un furibondo Herrera si reca in sede per chiedere al Presidente Moratti di cacciare il ribelle Corso. La richiesta, cosi come sarà per molte altre volte in futuro, è cestinata dal dirigente nerazzurro, troppo innamorato delle prodezze del fantasista per immaginare di poterlo vedere in un’altra squadra.
Trionfi e delusioni
In ogni caso la disistima reciproca non impedisce ai due di collaborare fattivamente per dare vita al ciclo della Grande Inter dei primi anni Sessanta. Uno dopo l’altro i trofei vanno ad arricchire la bacheca della società nerazzurra: quattro scudetti, due Coppe dei Campioni, due Coppe Intercontinentali. In quest’ultima competizione il suo apporto è determinante: un suo gol, allo scadere dei tempi supplementari della terza partita contro l’Independiente, regala il trofeo ai nerazzurri. In nazionale, invece, non riesce a prendersi molte soddisfazioni e deve accontentarsi di alcune perle isolate, come la doppietta con cui stende Israele nelle qualificazioni ai Mondiali del 1962. Il tecnico degli avversari commenta, ammirato, che “quello è il piede sinistro di Dio”. Tuttavia, i suoi atteggiamenti disturbano più di un allenatore e spesso viene tagliato fuori dalle convocazioni. Quindi, nei rari casi in cui scende in campo con la maglia azzurra, il rancore lo porta anche ad iniziative spiazzanti, come il gesto dell’ombrello rivolto all’allenatore Ferrari, dopo un gol segnato in amichevole.
Addio all’Inter
Herrera lascia la squadra nel 1968, in coincidenza con la fine del ciclo di vittorie, per inseguire gloria e successi altrove. Corso, liberatosi del rivale, rimane fedele al club della sua vita, accettando anche di giocare in una squadra con ambizioni ridotte. Dato che gli anni passano e Suarez ha chiuso la carriera, si incarica anche di sostituirlo in formazione, arretrando il suo raggio di azione e trasformandosi da attaccante esterno in interno di regia. Sono anni di transizione per l’Inter, i pochi risultati conseguiti inducono il nuovo presidente Fraizzoli a richiamare Herrera in panchina per puntare ad altri traguardi. La prima condizione che pone il tecnico argentino per tornare alla guida della squadra è l’allontanamento di Corso. Il nuovo dirigente non ha la forza di opporsi e questa volta è il giocatore che deve fare le valigie, destinazione Genoa per un mesto finale di carriera tra infortuni e retrocessioni.