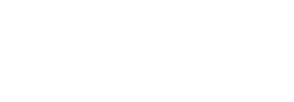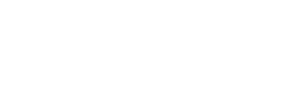Approfondimenti
Capolavoro senza tempo

Era il luglio del ’94. Negli USA, l’Italia si giocava la finale dei Mondiali col Brasile. La partita, conclusasi sullo 0-0, si decideva ai rigori. Toccò a Roberto Baggio. La tensione era altissima perché lui, di quei Mondiali, era stato il simbolo. Il destino azzurro era nei suoi piedi. Ma il tiro, alto, segnò la fine di un sogno che era sembrato davvero vicino ed alla portata e che, invece, avevamo solo accarezzato. Quegli istanti sono impressi nella mente di tutti gli amanti del calcio e di quei momenti si tendono a ricordare anche piccoli particolari.
Fu allora che mi focalizzai per la prima volta sul significato di una canzone che accompagnava le diverse immagini dei rigori sbagliati da Baresi e Baggio. Quella canzone era “La leva calcistica della classe ’68”.
Tutto il pezzo è una metafora. Ma questo lo sanno bene gli appassionati di De Gregori, abituati ad un linguaggio così simbolico ed evocativo. Ed una delle metafore più efficaci per spiegare il mondo è il calcio. É per questo che il gergo calcistico è entrato a pieno titolo nella lingua comune.
La canzone, scritta nel 1980, racconta la storia di un provino di un ragazzo di 12 anni che si approccia con timore a quell’evento. Il pezzo è stato definito dall’AIAC, Associazione Italiana Allenatori Calcio, come la storia di tutti gli appassionati ed aspiranti calciatori italiani. La storia di tanti ragazzini che sognano di diventare famosi racchiusa in un brano che si focalizza sul senso più alto e puro di questa disciplina sportiva. Quando la canzone ha vinto il premio “Football Leader 2015”, De Gregori si è espresso con le seguenti parole: “Ho scritto questa canzone pensando ad un bambino che il pomeriggio, su un campetto sterrato, impara il senso ed il limite della competizione, impara il successo ed il fallimento, la paura e la gioia di vincere. Tutto questo è ancora nel sentimento del calcio giocato, a tutti i livelli, anche in una finale di Champions”.
Ad un primo ascolto, in effetti, pare che il pezzo descriva la storia di un provino ma di fatto la canzone, già dal titolo, risulta intrisa di simboli e significati e si appresta ad essere interpretata secondo diverse chiavi di lettura.
Classe ’68 non è casuale. Il ’68 è stato un anno di rivoluzioni, di movimenti politici, culturali e sociali, durante il quale sono emerse le insofferenze e i sogni di tanti giovani che volevano cambiare il corso delle cose.
“Sole sul tetto dei palazzi in costruzione”: il pezzo inizia con queste parole che indicano qualcosa che è in corso d’opera e simboleggiano l’azione, il rimboccarsi le maniche. E quei palazzi sono illuminati dal sole, quindi è tempo di costruire: la vita, un sogno, la lotta. Almeno fino a quando, in un tempo diverso, quei palazzi non più illuminati dal sole, diventeranno simili fra loro, quasi a rappresentare la rassegnazione dei sogni infranti.
“Sole che batte su un campo di pallone”: qui comincia la metafora col calcio. Nino scende in campo nella vita, comincia a giocarsela, con la consapevolezza di poter contribuire in prima persona ad un cambiamento.
“E terra e polvere che tira vento e poi magari piove”: sembra quasi l’immagine di un film di Pasolini questa descritta così bene da De Gregori con tutto il realismo suo e del tempo. In una realtà che spegne il sogno (terra, polvere) si percepisce comunque il desiderio di continuare a sognare. Quel “magari” sconvolge il senso di sicurezza perché non c’è nulla di certo. E infatti… piove. Ma, nonostante tutto, bisogna continuare a sognare, senza aver paura.
“Nino cammina che sembra un uomo, con le scarpette di gomma dura, dodici anni e il cuore pieno di paura”: E Nino ha paura proprio perché ha un sogno e questa vita lui vuole provare a cambiarla davvero. Nino ha paura di non farcela e di finire “a ridere dentro a un bar” come quei “giocatori che non hanno vinto mai ed hanno appeso le scarpe a qualche tipo di muro”. Nino ha paura perché si sta assumendo in prima persona la responsabilità personale di tirare ed eventualmente anche di “sbagliare un calcio di rigore”.
Nino è anche e soprattutto un uomo. L’uomo che vince le sue paure e sa di poter realizzare il suo sogno. Da qui comincia l’intenso parallelismo con la vita: “Nino capì fin dal primo momento, l’allenatore sembrava contento “. Nino “capisce”, è consapevole perché il desiderio di realizzare il suo sogno è dentro di lui, fa parte della sua storia da sempre ed attende solo la possibilità, l’allenatore che lo schieri in campo, l’adulto che creda in lui e che gli dia l’opportunità di poter mettere “il cuore dentro alle scarpe” e correre “più veloce del vento” con quell’istinto di vita che funge da valore propulsivo, col desiderio di autorealizzazione che alimenta e sostiene le sue scelte ed i suoi sacrifici.
E allora Nino “prese un pallone che sembrava stregato, accanto al piede rimaneva incollato, entrò nell’aria tirò senza guardare ed il portiere lo fece passare”: Nino prende il pallone, lo fa suo, lo controlla e tira. Attraverso la splendida immagine del portiere che fa passare la palla, De Gregori vuole trasmettere l’idea che non è scontato che un sogno si realizzi. Ma anche se non si concretizza, anche se è stato solo sognato, poco importa. Nino per quel sogno ha lottato, anche se “magari” lo sorprenderà la pioggia. E forse un giorno anche lui farà parte della schiera dei magnifici perdenti che si sono giocati tutto in uno o pochi frammenti decisivi.
De Gregori li assolve. “Il ragazzo si farà, anche se ha le spalle strette, questo altro anni giocherà con la maglia numero sette”. Anche se sarà così, il Mister gli avrà dato comunque la maglia numero 7, come forma di gratificazione che certamente, alla fine della carriera, anche da “giocatore triste”, ripagherà per quel rigore tirato.
In chiave psicologica, Nino rappresenta ognuno di noi con i propri timori, insicurezze e dubbi. Soprattutto con la paura di sbagliare, di non essere all’altezza delle aspettative nostre ed altrui. Vi sono momenti decisivi nei quali emozioni e paure tendono a paralizzarci. Ma è proprio in quei momenti che dobbiamo imparare ad essere comprensivi e clementi nei confronti di noi stessi. Il coraggio non è la mancanza di paura ma la capacità di accettarla e di canalizzarla per funzionare meglio e per fare in modo che anche le circostanze volgano a nostro vantaggio. Ciò che conta, infatti, non è la volontà di vincere ma la volontà di prepararsi a vincere. Attraverso la percezione ed il riconoscimento dei propri limiti, è fondamentale sviluppare la consapevolezza del desiderio di migliorarsi.
Il brano è, però, anche la metafora del fallimento dei sogni e degli ideali di un’intera generazione, quella del ’68. In chiave politica, il pezzo si riferisce a quei giovani che cercarono di cambiare il mondo e che la storia, in qualche modo, non favorì. La canzone, peraltro, fu inserita nell’album “Titanic”, una nave che affonda, come gli ideali di civiltà che il ’68 inseguiva dopo anni difficili, “di piombo”, di crisi e stragi. E dunque “coraggio, altruismo e fantasia” rappresentano le qualità che la classe politica dovrebbe avere e che non ha mai avuto.
Un mese dopo l’uscita di “Titanic”, la maglia numero 7 di Bruno Conti vincerà il Mondiale di Spagna. E questa è storia.
De Gregori, da cantautore ricercato, raffinato ed eclettico quale è, ha dato sempre molto valore alle parole.
Del resto, come scrive Recalcati: “le parole sono vive, entrano nel corpo, bucano la pancia. Possono essere pietre, bolle di sapone o foglie miracolose. Possono far innamorare o ferire. Le parole non sono solo mezzi per comunicare ma sono corpo, carne, vita, desiderio. Noi siamo fatti di parole, viviamo e respiriamo nelle parole”.
E adesso provate ad ascoltare la canzone. Vi renderete conto che è proprio così.
(foto di Repubblica.it)