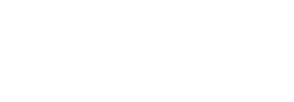Approfondimenti
NUMERO 14 – La seconda squadra
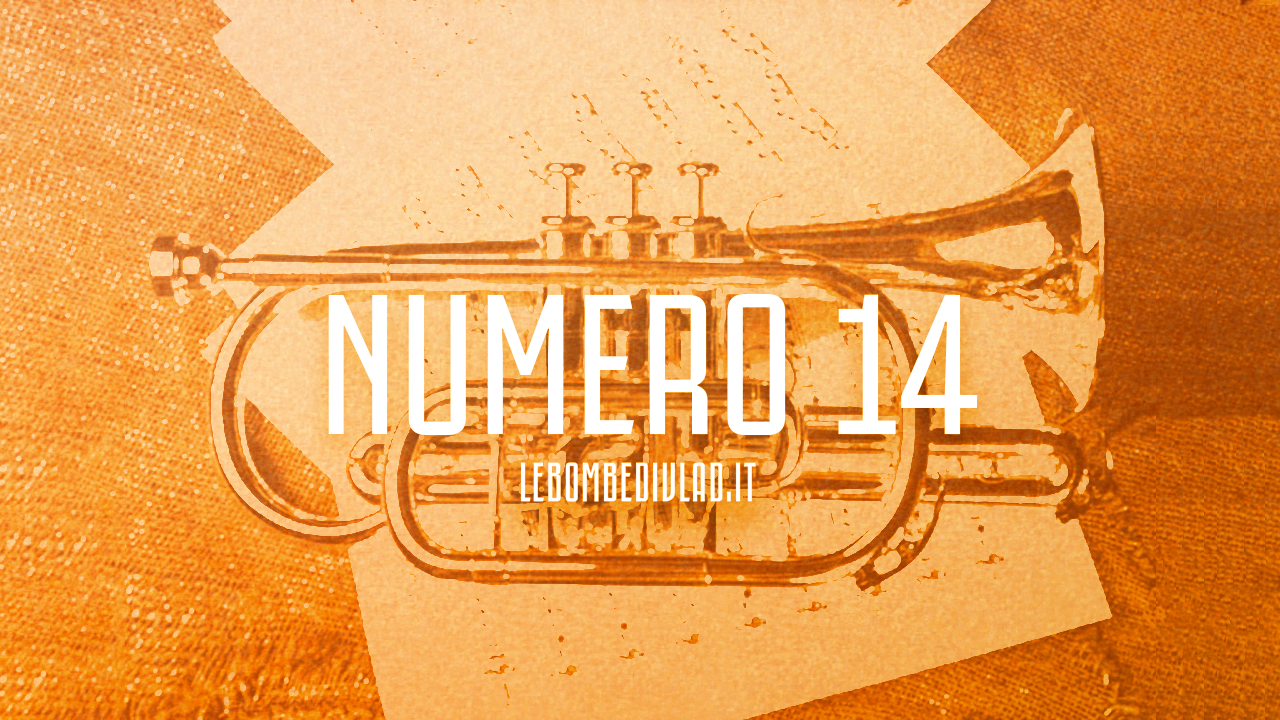
Secondo la definizione di Wikipedia la “seconda squadra, detta anche squadra riserve o squadra B, è organizzata da una società sportiva per far giocare riserve, giovani o giocatori che devono recuperare da infortuni”.
Aggiunge, inoltre, l’enciclopedia online che la seconda squadra “milita solitamente nei campionati minori, mentre la prima squadra è spesso iscritta alle divisioni superiori”.
Un rapporto di stretta interdipendenza, quindi, tra due compagini accomunate dalla medesima proprietà che implica un legame di carattere subordinato di una nei confronti dell’altra. Al punto che si potrebbe persino usare un termine desueto come “vassallaggio”.
Le seconde squadre sono esistite sin dagli albori del calcio.
In Italia si ha notizia della loro presenza sin dal 1904, ben prima dell’introduzione del girone unico, con la disputa di tornei a loro riservati (Campionato Riserve, Campionato De Martino, Campionato Cadetti, Campionato Primavera) con il dichiarato obiettivo di consentire ai giocatori militanti nelle loro fila di accumulare esperienza, riprendere l’attività agonistica oppure di mettersi in mostra.
Per fare ritorno alla prima squadra o approdarvi per la prima volta.
Il sistema delle seconde squadre fu in vigore fino alla fine degli anni Settanta, quando si decise di abolirle anche per attribuire parte delle loro funzioni alle formazioni giovanili, in modo da valorizzare i vivai.
Ma far coincidere la seconda squadra con la formazione primavera e incentrarne l’attività sulla sola formazione dei giovani alle proprietà non conveniva affatto.
Infatti, private di un approdo sicuro (e a costo zero) per atleti ormai fuori dal progetto a causa di problemi fisici o incompatibilità ambientali, le società si videro costrette a rimediare adottando un complesso sistema di prestiti e comproprietà per smaltire le eccedenze nella rosa della prima squadra.
Non si poteva più retrocedere il giocatore infortunato o problematico nella squadra B e poi attendere che guarisse oppure si mostrasse più conciliante con tecnico o dirigenti. Si rendeva necessario prestarlo ad un altro club per una stagione e sperare che il cambiamento d’aria gli giovasse almeno quel tanto che bastava per ritrovare una buona forma fisica, rivalutarsi ed essere rivenduto a buon prezzo dodici mesi dopo.
Sempre che la squadra in questione ritenesse conveniente valorizzare un giocatore altrui facendolo giocare al posto di un calciatore di sua proprietà.
Non era infrequente, infatti, che, al termine dell’anno di prestito, le società si ritrovassero tra i piedi un calciatore con il morale sotto i tacchi dopo una stagione intera in panchina a veder giocare gli altri.
Difficile tenerlo in squadra, ancora più difficile trovargli un’altra sistemazione.
Nel caso della comproprietà la situazione era completamente diversa: il cartellino del giocatore era diviso equamente al 50% tra le due squadre.
Al termine del campionato, a seconda del rendimento del calciatore e delle esigenze delle squadre, ci si accordava sulla definizione della comproprietà, nella maggior parte con un gentleman’s agreement mentre, in caso di contrasti tra le due dirigenze, la decisione era affidata alle buste.
Due plichi ben chiusi con dentro la somma offerta per il cartellino.
La somma più alta offerta attribuiva la proprietà del giocatore.
Un metodo molto rischioso, dagli esiti spesso imprevedibili.
Paradigmatico, in questo senso, il mancato ritorno di Paolo Rossi alla Juventus nel 1978 dopo che, all’apertura della busta, si scoprì che il Vicenza, comproprietario del cartellino, aveva messo una cifra enorme per riscattare la metà del suo cannoniere ed uomo-simbolo.
Su questa vicenda ci torneremo, è una promessa.
A quel punto, constatato l’imprevedibile alea del metodo delle comproprietà e gli esiti fallimentari dei prestiti, le varie società si trovavano alle prese con il problema delle rose ipertrofiche, piene zeppe di calciatori da collocare al più presto altrove onde evitare di avere troppi stipendi ad appesantire i già sofferenti bilanci.
E, in quegli anni, ci si poteva trovare di tutto in una rosa di 22 elementi: l’eterna promessa mai sbocciata, il talento inespresso, il veterano mai uscito dalla mediocrità, il piede vellutato limitato dal carattere difficile.
Rendimento insufficiente per molti ma contratto in vigore per tutti.
E qualcuno doveva pur togliere il disturbo, almeno per contenere le spese.
A soffrire di questa situazione, sul finire degli anni Ottanta, era soprattutto il Milan di Silvio Berlusconi: la voglia di grandeur del Presidente rossonero aveva originato, tra le tante altre cose, un autentico rastrellamento di giovani promesse del calcio.
Con l’obiettivo neanche troppo nascosto di trasformare le giovanili rossonere in una fucina di grandi campioni, sull’esempio del Castilla, la seconda squadra del Real Madrid, il club dove si erano formati molti degli attuali pilastri delle merengues, tra cui Butragueno, Michel, Sanchis e Martin Vazquez.
Il patron milanista era affascinato dall’idea di creare una filiale del suo club dove allevare giocatori secondo i suoi metodi. E farne delle stelle di prima grandezza.
In un primo tempo aveva considerato l’idea di impadronirsi del Como e, oltre all’ingaggio di alcune promesse lariane come Borgonovo e Simone, aveva dirottato sul lago anche il suo pupillo argentino Daniel Borghi per un proficuo apprendistato al calcio italiano prima di indossare la casacca rossonera.
Forse per l’esito infausto dell’operazione Borghi, forse per altri motivi, la joint venture tra le due squadre non riusciva a concretizzarsi e, quindi, le attenzioni del Milan si rivolgevano verso il Monza.
La squadra brianzola sembrava avere tutti i requisiti adatti allo scopo: contiguità territoriale, dirigenza più che disposta a collaborare e comunanza di idee.
Ultimo ma non ultimo: Adriano Galliani, A. D. milanista, era originario proprio della zona ed era stato dirigente della squadra.
L’inizio del sodalizio affaristico-sportivo sull’asse Milano-Monza era stato l’invio di Alessandro Costacurta, ventenne speranza delle giovanili milaniste, a farsi una stagione in prestito in Brianza.
Il giovane difensore avrebbe sfruttato l’occasione per disputare il suo primo campionato da titolare e farsi cosi le ossa per tornare al Milan da protagonista.
In realtà il motivo che lo aveva spinto ad accettare Monza era soprattutto la vicinanza: aveva perso da poco il padre e non voleva allontanarsi troppo dalla sua famiglia.
Ma intanto la strada era stata tracciata e, negli anni successivi, molti prodotti del vivaio rossonero avevano preso la strada della Brianza.
A dire la verità non proprio tutti erano di primo pelo: anche un onesto mestierante come Giulio Nuciari, per molti anni portiere di riserva dei rossoneri, venne dirottato a Monza per un dignitoso finale di carriera.
Per il resto, si trattava in gran parte di giovani di belle speranze che, però, alla fine risultarono tutti non all’altezza delle aspettative.
Agli appassionati di calcio odierni i nomi di Zanoncelli, Cappellini o Mancuso non dicono molto mentre un Giovanni Stroppa lo si ricorda a fatica come un comprimario.
E non sempre la collaborazione tra i due club dava i frutti sperati: il gioiellino delle giovanili monzesi, Pierluigi Casiraghi (esordio ad appena 16 anni) veniva venduto alla concorrente Juventus mentre il portiere Francesco Antonioli, approdato a Milano con la fama di sicura promessa del ruolo, finiva per bruciarsi la carriera ad alti livelli per un banale errore nel derby della Madonnina.
Nonostante tutto, il Monza si identificava sempre di più nel progetto della casa madre rossonera, al punto che in panchina si avvicendavano vari allenatori, come Franco Varrella o Pierluigi Frosio, il cui principale merito consisteva nell’essere convinti fautori del gioco a zona e, quindi, in perfetta assonanza con il credo calcistico del Vate milanista Arrigo Sacchi.
Intanto, nonostante le buone intenzioni e il supporto di un club di rilievo come il Milan di quegli anni, il Monza restava ben lontano dagli obiettivi prefissati e i bei ricordi della fine degli anni settanta, quando il club aveva sfiorato la promozione in serie A per ben quattro volte, non trovavano alcun riscontro nel rendimento odierno del club, abbonato a una alternanza tra serie B e serie C che non sembrava avere mai fine.
Gli unici successi da annoverare nel palmares erano un paio di Coppe Italia di Serie C, davvero troppo poco per una squadra che ambiva ad essere un sorta di laboratorio per far nascere giocatori adatti a una grande realtà del calcio italiano come il Milan.
Ma il destino di un satellite non può mai essere diverso dal mero orbitare attorno al pianeta di massa superiore.